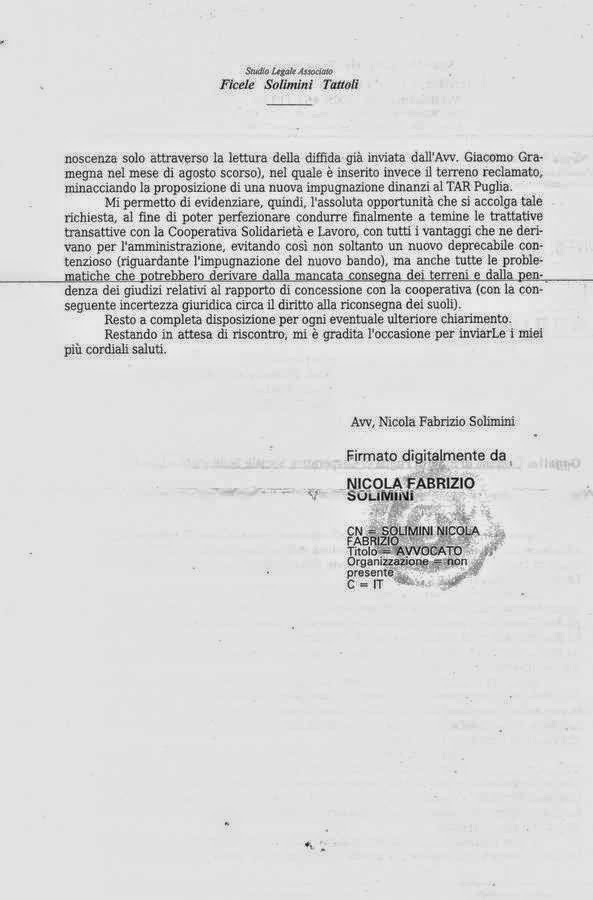IL SALTO
Non erano ancora scoccate le nove quando decise di farla finita con quel preciso partito, di più, con la politica.
Avrebbe messo una pietra sopra ai vent’anni di attivismo, alle cariche di facciata, agli interminabili discorsi su cui si sarebbero volentieri posate le mosche cavalline, se mai quelli avessero potuto materializzarsi, alle confuse sedute preconsiliari, dove tutti parlavano di tutto perché alla fine si affermasse il parere di chi strillava di più, ai vertici estenuanti, alle riunioni pregne di fumo del direttivo sezionale, a cui ormai partecipavano dalle sei alle sette persone, animate sempre da una gran fretta di andare.
Sanciva la fine di un lunghissimo sodalizio con certi ideali, vissuti con il massimo di purezza possibile all’uomo, che giorno dopo giorno aveva visto sfarinarsi nei comportamenti del capopartito, il quale, tronfio e gonfio come un pavone, accentuava in tutte le occasioni le manifestazioni di potere di cui era capace. E poiché ogni accentuazione di potere sconfina nell’abuso e nell’autoritarismo, tanto deprecato nelle assemblee democratiche, lui non faceva mistero della sua vocazione autoritaria e decisionista, perché – erano sue parole, pronunciate in contesti assai ristretti – la gente non ama la democrazia, ma rispetta, anzi venera l’uomo autoritario, forte, implacabile, e questo per l’enorme senso di responsabilità individuale che il regime democratico richiede e che nessuno vuole accollarsi, in particolare gli italiani, i meridionali, borbonici fin nelle budella.
Il leader parlava per ore ed ore, godeva nell’essere ascoltato, teneva con lo sguardo acuminato la contabilità degli applausi e mandava a memoria i volti e le espressioni dei distratti e di chi non applaudiva; sbavava interiormente per le sue lungimiranti intuizioni, per il timore reverenziale che incuteva sui dipendenti comunali, sugli esponenti degli altri partiti, sugli uomini del suo partito, ridottosi ad uno sparuto gruppuscolo di legionari al servizio del principe.
Così, ai minimi termini, si era ridotta la politica, la partecipazione popolare alla delineazione dei destini magnifici e progressivi di quella manciata di umanità che viveva, soffriva, gioia e sperava in quel paesotto collinare, ameno, bello a vedersi, dove l’aria era pulita e salubre, almeno quella.
Era un bel paese con un bel centro storico, strade larghe ed assolate, corsi alberati, un clima temperato fino ad ottobre inoltrato, ricchezze naturali ed archeologiche che affioravano e che i costruttori edili, quella razza deturpatrice e devastatrice di uomo, occultavano, depredavano e distruggevano con una mazzata di pala meccanica per non soggiacere alle fini lungaggini burocratiche ed ai vincoli della Soprintendenza Archeologica, e non dover assistere, loro uomini rudi, alle delicatezze e cautele degli archeologi che, come delle femminucce, coi loro pennelli e palette accarezzavano quegli avanzi di polvere mummificata come se si trattasse del viso di un loro caro congiunto.
Mentre per gli studiosi la storia aveva un senso, perché nella storia c’era tutto il loro presente, criptato, da interpretare, persino i loro lineamenti, per i costruttori il passato era passato: che cosa potevano contare nell’era della deregulation, della spicciatezza, due o tre anfore a corredo di un uomo morto duemila anni prima, una lancia spezzata, una spada corrosa? Meglio metterci una pietra sopra a quel sepolcro sbucato per sfotterli mentre loro, le maestranze, erano al lavoro: i tempi di consegna erano stretti, tutti andavo di fretta, proprietari di prime, seconde, terze case, in cooperativa e in edilizia privata convenzionata, amministratori comunali, ingegneri, geometri e politici, i quali non attendevano altro che di poter posare, sorridenti, calcolatori e distesi, dinanzi ad un fotografo per la cerimonia di consegna degli appartamenti a chi ne aveva un bisogno estremo. Una forte stretta di mano col presidente della cooperativa edilizia avrebbe sancito l’esistenza di un rapporto privilegiato e di pubblica riconoscenza reciproca: checché ne pensasse l’opposizione, la cementificazione del territorio, i1 fumus affaristico, il clientelismo, il voto di scambio erano degenerazioni sistemiche presenti ed agenti altrove, non certo lì, dove tutto avveniva all’insegna della trasparenza e della legalità. La circostanza che gli appartamenti venissero consegnati proprio una settimana prima delle elezioni amministrative, era un caso, solo un caso fortuito, e male faceva l’opposizione a ricamarci sopra, a tappezzare i muri della città con manifesti infamanti: ne avrebbero pagate le conseguenze politiche, non sarebbero mai divenute forze di maggioranza a causa della intrinseca debolezza delle loro argomentazioni, oltre che delle loro relazioni.
Nel suo paese i costruttori andavano molto d’accordo con i politici che contavano, ed i prezzi delle case erano molto elevati. Circostanze occasionali, fortuite, o meglio inevitabili: erano la legge del mercato e la legge della politica che si imponevano al di là delle intenzioni e degli scrupoli d’ognuno. La legge del mercato pone al centro il profitto, lo esalta, lo divinizza; la legge della politica mette al centro il profitto, lo esalta, lo idealizza, facendolo apparire come la leva di cui la politica si serve per ridistribuire redditi e possibilità, ovviamente a favore di se stessi. Divinizzare il profitto no, questo no: non era da cristiani impegnati nella difficile ed esigente arte della politica, e loro dovevano pur sempre tenere presente la distinzione fra Cesare ed il Padreterno.
Confutare le leggi del mercato e della politica equivaleva a fermare la corsa del mondo: non era realistico; era solo il sogno perennemente infranto delle anime belle, quelle che, tutt’al più, nel silenzio di un romitorio, possono pregare ed attendere serenamente alle faccende spirituali, in cui nulla si tocca, nulla si desidera, cose o donne o denari, nulla aggrava il volo dell’anima verso i suoi eterni destini. Se lì si vola, qui si fa da conto e non vi è traccia di preoccupazione per l’attacco della tignola. Ed il cristiano, pure lui, le mani doveva sporcarsele nelle infime questioni mondane: era l’incarnazione stessa del Cristo a pretenderlo, e, poiché la realtà tutta era percorsa da commistioni, trame, compromessi, si doveva per forza di cose accettare il peccato, conviverci, seppure dolorosamente. L’uomo pio non aveva scampo: doveva farsi peccato per essere assolto alla fine, essendo il peccato una dura realtà presente nelle azioni politiche, quelle che debbono compiersi perché fosse proseguita l’opera creatrice iniziata dal Creatore.
Lì, quindi, in quel paese così diverso da ogni altro paese italiano, i costruttori costruivano e si arricchivano, ed i politici facevano politica e si arricchivano, costituivano insieme un unico, grande, potente partito, per cui finalmente l’antifona si era capita: quando si parlava di “costruire una nuova politica”, si intendeva alludere al rapporto privilegiato, quasi di immedesimazione, fra edificatori e politici, alle leggi del mercato e della politica che viaggiavano parallelamente, identiche negli esiti, nelle regole e nei principi tranne che per l’unica, ininfluente e filosofica differenza tra idealizzazione e divinizzazione del profitto. E la novità atteneva unicamente alla forma, nel senso che dallo scudocrociato o dalla falce e martello o dal sole nascente si era passati alla botanica gentile, al fior di campo cortese ed umile, a quello affamato di luce che segue il sole, alla robusta quercia secolare o alla rosa che, come una donna pudica, custodisce gelosamente il suo bocciolo. Ma, secondo lui, smaliziato, smagato, con gli orecchi e l’anima provati da decenni di politichese e di abortiti rinnovamenti, tutto era diventato paccottiglia, anzi, visto che era il tempo della botanica e che si stava avvicinando il mese di novembre, crisantemo.
Ah, la filosofia! La filosofia e la politica, storia di un rapporto impossibile, incestuoso, riprovato… Saverio si accorse di aver toccato un altro punto scabroso, sospinto a ciò forse dall’idea del crisantemo, che richiama alle dolenti realtà ultime. La filosofia, la sapienza, la saggezza, l’interpello, la risposta alle tre domande capitali, il dopo, il modus vivendi e quello agendi, il benessere, che cosa ci azzeccavano con la politica?
La filosofia era pensiero, la politica era fare, e nessun politico in quei giorni, come nel sesso, faceva facendo precedere l’atto dal pensiero: l’atto ne avrebbe inevitabilmente risentito, anzi sarebbe risultato impedito, allo stesso modo di come sarebbe stato impossibile fare l’amore facendo precedere il congiungimento carnale da un’invocazione al Signore, come aveva suggerito un sacerdote ad un gruppo di fidanzati che si preparavano al sacramento del matrimonio, peccando di inesperienza: la cosa non sarebbe riuscita, sarebbe stata soffocata dall’insorgere dei sensi di colpa, legati indissolubilmente al sesso congiunto ai precetti.
La filosofia argomentava intorno all’ombra, rifletteva sulle ombre ed arrivava a concludere che l’ombra era il riposo della luce, un po’ come la poesia, che partoriva l’invisibile o l’obnubilato sentimento dell’essere.
La politica, un politico delle sue parti, si chiese Saverio, che cosa avrebbe potuto dire sulle ombre, con cui, in un certo senso, qualche dimestichezza ce l’aveva? Che sono il riposo della luce, quindi luce anch’esse? No, avrebbe detto, poggiandosi sull’evidenza e sulla propria esperienza (tutti parlano di loro quando parlano degli o agli altri), che le ombre sono la morte della luce, la assorbono, la catturano, e che tutto il resto era, per l’appunto, inservibile filosofia.
E della vita, che cosa ne pensava il politico nostrano? Che era un arco di tempo abitato da un’esigenza, amare ed essere amati? Troppo dolce, troppo melenso, soprattutto troppo lontano dal vero. Avrebbe sostenuto che era un’arena dove ci si affrontava per aggiudicarsi spazi di gloria, un arco di trionfo, la notorietà, il potere. Accecato dalla sua visione utilitaristica, avrebbe poi soggiunto che il potere chiama a sé l’amore, che é una conseguenza del potere. L’intrinseca potenza dell’amore era un’invenzione degli incapaci e dei falliti, un filosofema, una blasfemia. Le religioni esaltavano l’amore? A parte la circostanza che abbracciavano la fede il disilluso, lo stanco, il malinconico, le religioni andavano totalmente abolite perché tutti i rapporti umani erano da sempre rapporti di forza, spesso di forza bruta, micidiale. Poteva dirsi una vittoria la morte del Cristo sul legno della croce? Chi muore ha perso, non ha vinto, e soprattutto non ha potuto godersi l’unica vita che abbiamo.
Questo avrebbe detto il politico ruvese, semmai con altre parole, attingendo inconsciamente un po’ a Spinoza, un po’ a Nietzsche e al Kierkegaard dello stadio estetico, un po’ anche a quel rigido concretismo riveniente dalla dura, atavica opera di coltivazione della terra: se produci sei ed ottieni amore; se non produci non sei, e l’amore si allontanerà da te, assumerà il volto torvo di una moglie in menopausa.
Già, rifletté Saverio, proprio dalla tradizione, dalla sana e celebrata cultura contadina provenivano i germi della scristianizzazione di quella landa pugliese, il neo-tommaseismo (da San Tommaso Apostolo, non dall’Aquinate), prima forma di dubbio post-cristiano, la più atroce perché vissuta in costanza di Cristo, che si compendiava nelle tre “t”: toccare, tastare, tirare le somme.
Cosa poteva l’umiltà contadina contro la pressante esigenza di strappare prodotti alla terra per ricevere amore? Il cristianesimo, che esaltava la virtù dell’umiltà, erroneamente aveva innalzato la cultura contadina a cultura universale, a recinto dentro cui la fede pascolava e si moltiplicava, mentre fuori, ad extra, allignava l’orgoglio, figlio delle rosse passioni.
Ora l’equivoco era finito, ed il cristianesimo, confidando nell’umiltà contadina, aveva in realtà allevato uno dei suoi carnefici, il più subdolo perché creduto il più vicino. L’umiltà non portava pane e potenza ed amore, il contadino aveva capito l’antifona: l’amore è appannaggio dei sacerdoti del culto della potenza. Altro che positivismo! Il nemico era dentro le mura, non c’era stato bisogno di un cavallo di Troia per decretare l’eclissi dell’amore come sentimento che viveva di vita propria, autonomo dal censo, e dunque l’insorgere di una volontà di potenza persino negli umili.
Saverio si accorse di essere andato oltre, forse di avere farneticato: dall’addio alla politica alla crisi del cristianesimo, il passo era stato lungo, e non aveva mai letto da nessuna parte che all’origine della crisi del cristianesimo non c’era l’illuminismo ma addirittura l’insospettata tradizione contadina, un moto di ribellione nato all’interno di essa e suscitato dall’ansia di potenza che domina il mondo.
La sua decisione di mollare la politica era irreversibile. Ma il mondo non c’entrava nulla, né c’entravano il denaro e la potenza, i massimi sistemi, ma la scoperta dei comportamenti, l’essersi trovato di fronte ad una crosta rugosa ed inscalfibile, l’aver cozzato contro di essa ed aver riportato serie ferite, non esterne, ma nell’anima, nel nucleo degli ideali, la cui sopravvivenza ed integrità in qualche modo dipendono dall’altrui modo di essere. Gli occhi, i suoi occhi, avevano veduto inasprirsi i lineamenti del dominus; pure quelli dei suoi scherani si erano improvvisamente induriti, anzi, per una forma di acuto servilismo, erano semmai più aspri di quelli del padrone: nessuna critica era consentita a chicchessia, interno od esterno, anzi a maggior ragione non era permessa ad un interno, che attenuanti non poteva averne: agli albori della carriera del dominus, quando era ancora animato da autentico spirito di servizio ed era lungi da lui l’idea di volgere la politica ad uso e consumo proprio (c’è sempre un periodo di noviziato in cui dominano i valori, lo spirito, le ansietà del prossimo), lui, Saverio, era stato uno dei suoi più ferventi sostenitori, e lo era stato per un bel pezzo, anche dopo l’apparire dei primi, inequivocabili segni di un cedimento dei leader alla seduzione del denaro. Quando lui ed il leader parlavano di terreni, case, depositi bancari, malaffare, il leader si lanciava in anatemi terribili contro i corrotti: era il primo segno, lo comprese successivamente, di un’autentica passione per l’oggetto degli anatemi, come succede spesso: si odia ciò che si ama a dismisura.
Ma quando il leader gli confidò, senza esserne richiesto, che lui aveva acquistato due appartamenti costosissimi in zona centrale e che aveva dovuto accendere un mutuo ventennale, allora la cosa gli fu chiara: mutui non ce n’erano, oppure erano stati contratti a copertura, i soldi c’erano, e forse c’erano pure i terreni e la villa al mare di cui parlavano le opposizioni. Quell’uomo che gli stava di fronte e che non lo guardava negli occhi non era onesto: perché gli aveva fatto quella confidenza? Voleva che lui fungesse da amplificatore, da cassa di risonanza, da divulgatore acritico della sua versione? Non lo fece, rarefacendo le sue apparizioni alla sede del partito, mentre gli frullava nella testa un pensiero di don Luigi Sturzo a proposito della disonestà e della ineluttabilità dell’espiazione delle colpe.
Ed il giorno in cui fu convocato dal leader nel suo ufficio e si sentì dire, fuori dai denti, che l’amicizia non esisteva, gli caddero totalmente le squame dagli occhi: ci vide chiaro, vide chiaro nel cuore di quell’uomo, e comprese tutto il senso della frase che Gaetano Salvemini scrisse nel lontano 1924 all’amico Tommaso Fiore: la politica militante non è cosa per gente onesta. Una frase lontana per condotte attualissime e future, ed anche, per lui, un indirizzo di ordine morale, anzi un imperativo categorico a lasciar perdere ogni velleità di poter fare politica onestamente. L’onestà, la rettitudine, i valori erano parole morte, luci fioche, pietre miliari su strade dismesse.
Quell’impasto di disumanità, assenza di sentimento, sete di potere, ambizione, amore per la ricchezza che il leader aveva rivelato impediva la prosecuzione di qualsiasi rapporto. Lui, in fondo, restava una persona onesta, e poi, per indole, amava la tranquillità, che non valeva la pena smarrire per tutto l’oro del mondo, che talvolta scivolava in una specie di torpore, di indolenza, di menefreghismo.
Verso le dieci, prese carta e penna e scrisse qualche frase di commiato. Frasi di circostanza, giustificazioni generiche (motivi di famiglia, impegni sopraggiunti, dare spazio alle nuove leve), larvati addebiti alla politica di quel tempo, maggioritaria nella forma e minoritaria nel paese e nelle coscienze rettamente formate. Non fece nessun cenno al leader per non aizzarne le passioni. Chiuse la busta, si vestì e scese ad imbucarla. Il leader ed il suo entourage non lo interpellarono più; la politica mise una pietra tombale su di lui e le sue mène da moralista. Il gran salto era compiuto. Di tanto in tanto gli giungevano segnali soffusi da quel mondo aspro, ai quali rispondeva facendosi il segno di croce.